



 Fonte "Le 95 Tesi di Lutero e la rottura con Roma"
Fonte "Le 95 Tesi di Lutero e la rottura con Roma"

Johann Von Staupitz
 Fonte "Lutero prima del 1517, una vocazione non matura"
Fonte "Lutero prima del 1517, una vocazione non matura"

 Fonte "La ragione separata dalla fede, i prodromi dello scisma luterano"
Fonte "La ragione separata dalla fede, i prodromi dello scisma luterano"
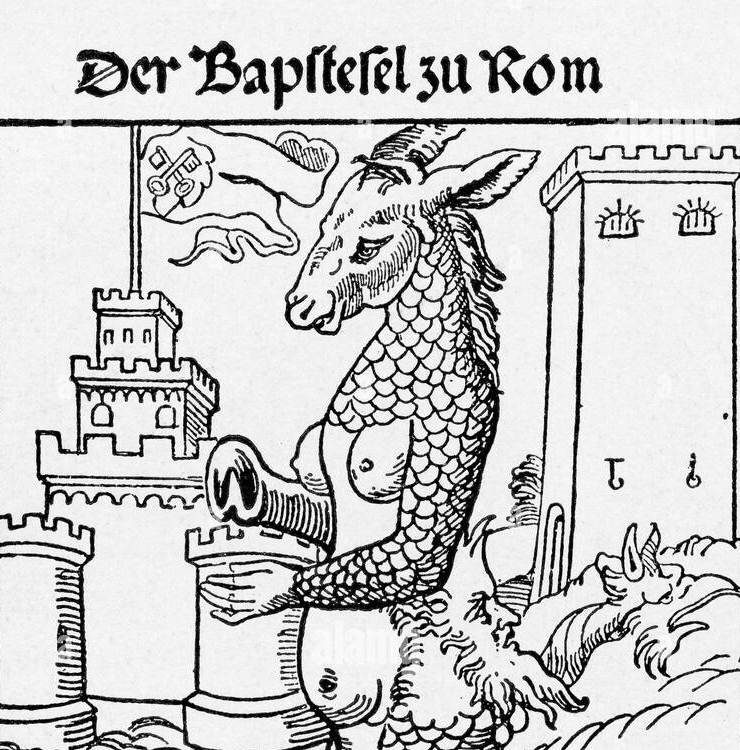
 Fonte "Lutero e la propaganda per istigare i principi tedeschi"
Fonte "Lutero e la propaganda per istigare i principi tedeschi"
